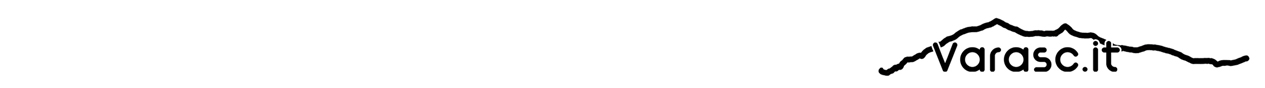

Roccia Nera e Quota 4106, agosto 2015
Una strana stagione estiva, quella del 2015, caratterizzata da un fenomeno particolarmente deleterio per le alte quote delle Alpi: il caldo innaturale, per certi versi allarmante, che ha imposto un duro tributo in termini di perdita di volume ai nostri ghiacciai. Dopo le prime salite alpinistiche sperimentate da Varasc.it nei mesi di giugno e luglio (il Gran Paradiso, la traversata integrale del Castore, la Piramide Vincent e il Balmenhorn) le condizioni del manto glaciale hanno subìto un netto peggioramento: crollo dei precari ponti di neve, comparsa di crepacci di particolare ampiezza e insidiosità, il collasso e l’apertura di una profonda faglia a semicerchio, estesa dal Balmenhorn al Naso del Lyskamm, sul Monte Rosa.
In base all’esperienza personale, all’osservazione dei primi dati glaciologici pubblicati da fonti certificate e dai resoconti delle Guide e degli amici alpinisti, chi scrive ha quindi deciso di soprassedere: avrei atteso il momento più favorevole, se non proprio il migliore, per tornare lassù. L’idea, sin dall’inizio, era semplice: attendere il mese di settembre, le prime nevicate tardo-agostane che da sempre scandiscono la fine dell’estate, per salire e scoprire con i miei occhi i danni causati da questa torrida stagione, trascorsa con lo zero termico stabile sui 4000, 4800 e perfino 5000 metri per molte settimane.
Per fortuna, l’idea si è rivelata vincente. Per fortuna e grazie a una persona speciale.
Martedì 18 agosto, alta Ayas. Piove. In compagnia dell’amica Chiara ho lasciato, dopo una lunga pausa piovosa, il Taconet alla volta di Soussun, dove l’antico e raro mulino Walser giace sempre nella rovina, anno dopo anno. Tra Resy e Beau Bois, dove pranzeremo chiacchierando di Ayas e di tanti argomenti cari a chi ama queste montagne, il dannato telefono cerca disperatamente di attirare la mia attenzione, mettendo a prova la mia notoriamente scarsa pazienza per il suo intero, petulante genere. Il fatto che sia “volato” sulle rocce del Corno Vitello, durante la mia corsa Lago Perrin-Corno Bussola, non lo aiuta a esprimersi correttamente; l’assenza di campo nei boschi di Fiéry non migliora la situazione.
Roccia… fugio. Venerdì. …za pensione. Sei contento?
La conversazione incerta non mi lascia capire molto, ma ho intuito due punti fondamentali: la parola prenotato!, e il mittente. La mia amica, la mia compagna di cordata, Audrey. Rido, facendo due più due, ed effettivamente sì, sono contento.
Primo giorno. Al Guide d’Ayas
Venerdì 21 agosto, Rifugio Guide d’Ayas alle Rocce di Lambronecca. Lieto ritorno, con neve fresca lungo la rampa accidentata che risale dal martoriato Grande Ghiacciaio di Verra, scorto in pessime condizioni il 5 agosto durante la mia ultima salita solitaria. Io e Audrey abbiamo risalito tutto il sentiero numero 7, una volta ancora: lo stesso e bellissimo sentiero della mia infanzia, lasciando Saint Jacques alle 8.30 dopo una buona cena e una piacevole nottata nel mio comodo campo base ayassino, sorvegliati strettamente dallo Zerbion e dalla Piure. La mia amica ha tutto il tempo, carica com’è, di rimpiangere la mancata scelta della jeep che ci avrebbe potuti portare fino al Pian di Verra: come sempre negli ultimi mesi, ogni passo le costa un dolore innaturale alla schiena, all’anca, e conseguentemente una fatica improba che, se ne accresce la mia ammirazione, le complica le cose. Non sta male, né ha bisogno di alcun aiuto: soffre semplicemente, ma se la cava. E’ in gamba, continuo a ripetermi standole un po’ davanti e qualche volta dietro, molto più del sottoscritto che non suda nemmeno e non fa praticamente fatica, a questo passo forzatamente lento.
Sono ormai le 15.00 e ripenso alla salita mattutina. All’elicottero della Pellissier che, per tutta la mattina, ci ha stressati sorvolando a bassa quota l’intero percorso per qualche carriolata di turisti paganti, troppo pigri per salire con le proprie gambe a vedere tutto ciò. Guardo il ghiacciaio ai miei piedi, le sue infinite crepe, ne percepisco la forza e il movimento, l’ablazione e l’occasionale crollo proveniente, tra le brume in risalita, dalla Gobba di Rollin. In alto, il sole gioca con effervescenti, eterei tentacoli di vapore, le bandiere schioccano liete, un paio di gracchi imbardano sicuri tenendomi d’occhio per conto di Wotan.
Sul mio taccuino, in un momento perso nel tempo e nel vento di quella spoglia terrazza, ho scritto: Bello esser qui con Audrey.
Lei ora è attivissima. Abbiamo addobbato la stanza numero 1, che divideremo con una tenera coppia di anziani elvetici, e scambiato qualche parola con Adriano Favre che è salito con noi. I gestori mi hanno perfino offerto una media; ho controllato l’attacco della traccia, appena oltre il rifugio, e trovato un paio di ciabatte quasi del mio numero. Un onesto e semplice biellese non dovrebbe desiderare di più. Audrey probabilmente avrebbe preferito ripararsi all’interno, malgrado mi risponda che va bene anche fuori, ma ha visto come mi sono eclissato sulla terrazza e mi ha seguito per un pranzo veloce. Ho scattato una foto a entrambi, Kinder in una mano e stupido cellulare nell’altra, tanto mi pareva improbabile tornare quassù prima del mese di settembre: e ora lei è qui con me, in silenzio, a gustarsi il pomeriggio e i ghiacciai.
La ragione per cui siamo tornati è semplice. Voglia di salire, e di rivedersi, a parte. Una serie di perturbazioni, di impulsi nordici ha portato piogge incessanti in Ayas, per più giorni, intorno a Ferragosto: pioggia trasformatasi in neve, in quota. Maltempo fino al 18 agosto, al 19: il 20, visti dallo Zerbion, i miei amati Quattromila scintillavano rinnovati. Abbiamo chiesto nel frattempo informazioni a più gestori, alle Guide alpine, e il responso era sempre stato positivo: due metri di neve sul Polluce, le condizioni ritornate ottimali, e le descrizioni della condizione dei crepacci che mi avevano rasserenato. Un piccolo miracolo, non in grado di supplire alla catastrofica calura precedente, ma certo un toccasana.
Non ci siamo limitati a richiedere informazioni a persone fidate, ovviamente. Abbiamo scelto un itinerario ben visibile dal basso, un percorso che conoscessi già. In grado di metterci alla prova, ma privo di facce o versanti nascosti e potenzialmente colmi d’insidie. Soprattutto, ho sfoderato la mia arma (non) segreta, la mia fida compagna di cordata, che al momento leva e indossa il suo piumino in base all’andirivieni del sole e delle nubi.
Audrey è nata per queste cose. Per la montagna. Non saprei immaginarla altrimenti, ad esempio in un centro commerciale, o dal benzinaio, o in qualsiasi posto privo di una dimensione verticale. Ed è curioso, perché non si tratta certo di un’eremita, e dunque presumo frequenti anche posti simili, come tutti.
In un mondo di sciocchi, illetterati e approssimativi bipedi con la licenza di parlare troppo, lei non si è mai limitata ad amare la montagna: l’ha studiata a fondo, diventando nel frattempo Guida escursionistica. Conosce i segreti del passare delle stagioni, la vita degli animali selvatici, il tipo di neve, la storia delle terre alte. Parla di Macugnaga con l’amore, la sicurezza e la passione che io sento nell’accennare ad Ayas. Non è una fatua collezionista di vette, perché ama e conosce quel che sale, andando oltre Wikipedia per documentarsi; ricorda quel che ha studiato, ascolta il prossimo e quando siamo insieme, dice sempre cose sensate o quantomeno interessanti. Soprattutto, è la mia compagna di cordata. La compagna di cordata della mia età adulta, quella che è sopravvissuta, con il trascorrere del tempo, all’attrito inevitabile degli anni e delle false amicizie. Danza tra un nodo a palla e un prusik, conosce le regole in base alle quali legarsi, la progressione su ghiacciaio e tutto il resto. E’ autonoma, e in lei mi vedo riflesso: non temo che a un certo punto, lassù, si volti dicendomi Non so fare qualcosa. Che non sia stata in grado di legarsi, da sola, i dannati ramponi. Che vada in palla, come dicono a Milano, collassando in crisi nervose nei posti e nei momenti meno indicati.
Audrey se la cava, soffre da matti e paga ogni passo, mi guarda le spalle e protegge la nostra cordata. Non pretende trattamenti privilegiati da Regina Margherita. Ha cura di me e, qualora mi sovvenisse qualche insana e pericolosa idea, avrebbe ogni titolo e un’assoluta mancanza di reticenze nel dirmi serafica: Stai per fare una cazzata. Qualità rare, rarissime, oggigiorno. Sul ghiacciaio slabbrato là in basso abbiamo incontrato tre skyrunner, in scarpette e shorts, salendo: urla, parolacce, imprecazioni dettate dal panico. Gente fuori posto. Animali spaventati e troppo testardi, ottusi, per non trovarsi lì. La mia lista di gente incapace, fotogrammi di un’epoca in cui tutti vogliono correre in cima e nessuno pensa mai di pagarne il prezzo, è lunga quanto la dichiarazione dei redditi di Trump.
Guardo Audrey che prosegue la sua relazione clandestina con il sole, togliendo e ripescando il piumino nero e giallo con flemma britannica, e penso che oggi non vorrei trovarmi qui con nessun altro al mondo. Costei, qualsiasi cosa succeda e qualsiasi grana possa saltare fuori dal cilindro insieme al coniglio, mi guarderà le spalle domani.
Tre e mezza?, mi chiede sbirciandomi. Il sole ora ci sta provando anche con me, e qualcosa collassa di schianto nelle brume, là davanti verso il Plateau Rosa. Tre e quarantacinque, provo a negoziare.
Secondo giorno. In alto
Splendida, piacevole serata, è l’etichetta sotto la quale ho salvato e archiviato mentalmente il dopocena precedente. Le foto al tramonto, le chiacchiere con i nuovi amici genovesi, l’ottima cena e il doppio dessert contrabbandato dalla mia vicina di tavola, che non lo gradiva. Una notte troppo calda per dormire professionalmente, seguita però da un risveglio sereno, allegro, impaziente.
Stelle, dappertutto: le costellazioni del mattino ammiccano sul velluto nero del cosmo, oltre che sul profilo severo della Ovest del Castore, mentre saliamo. Abbiamo lasciato il rifugio alle 4.40, Audrey in avanscoperta, ben legata. Le giornate si sono accorciate sensibilmente - bella scoperta - e il buio, rispetto a similari levatacce di quest’estate, è fitto: davanti a noi, nessuno. Avevamo una cordata cento metri prima di noi, appena oltre il rifugio, ma si sono fermati levando perfino gli zaini, e li abbiamo superati. Audrey procede piano. Le costa fatica e dolore, ma non si ferma mai lungo il solco della traccia. Mi segnala i crepacci, aperti o chiusi, e l’immagine che preserverò per sempre di quelle ore antelucane è toccante: questa ragazza, lo zaino rosso, la giacca blu con lo stemma, il berretto tricolore della Eisbär, che cammina nel nulla. Il buio sembra inghiottirla, perché la sua frontale emana una luce fredda, azzurra e violenta, diretta costantemente verso il basso; dove sfiora le sue braccia o le gambe, un colore ultraterreno bagna per qualche istante la stoffa lucida, e tutt’intorno è silenzio. La corda che le sussurra contro il fianco e corre verso di me, non esiste, è invisibile nel nero che ci separa; solo a volte emerge il grumo nero, in controluce, di uno dei due nodi a palla. Il ghiacciaio è un fiume nero, solo la traccia è costellata d’impronte e cavità, vive per qualche istante al calore effimero delle nostre torce frontali. Lassù brillano centinaia di microscopiche lucine, il frutto della fusione di altrettanti nuclei stellari, e immagino che anche noi due, su questa tavola nera, sembreremmo due piccole stelle per chiunque ci guardasse dall’alto.
Cinquanta minuti dopo, una cordata ci raggiunge e si affianca. La guida alpina scambia qualche parola con Audrey, il suo cliente boccheggia e armeggia con due bastoncini telescopici, dentro e fuori la traccia. Mi rovina l’equilibrio della notte, la simmetria, il ritmo da metronomo cantato finora dalle quarantotto lame dei nostri ramponi. Il vento pare non gradire a sua volta, e dal Colle di Verra scende sferzante ad aggredirci: chiuso nella mia giacca verde, ascolto gli schiaffi e seguo la mia amica.
Poco prima delle sei siamo alle roccette che, innalzandosi violentemente, segnano l’attacco della cresta sud del Polluce. Audrey fatica, e cento volte la sorveglio, controllo come vada, in una costante percezione della mia fondamentale inutilità nell’alleviarle questa sofferenza: so per esperienza che non servirebbe chiederle se vuole passarmi qualcosa, anche se risponderebbe gentilmente e senza risentimento, perché ha lo zaino semivuoto. E’ una sua piccola e personale odissea, un’anabasi al rovescio, un duello con qualcosa che vede e tocca solo lei: io, pur legato a lei e primo tra tutti nell’averne ogni cura quassù, orbito a distanza cislunare. A volte le scappa un gemito, si erge di scatto: quasi mi vergogno di star così bene.
Perché, in effetti, sto bene. Sento pozzi di energia inaudita, in cui si agita una voglia di fare nuova, infinita. Una vena profonda che emerge e, senza parole, fa percepire nettamente che non mollerò mai - né qui, ora, né altrove. Sono in Ayas, la valle che mi ha visto bambino e adolescente, il luogo in cui più sento vicine mia madre e mia nonna. Il loro pensiero apre infiniti percorsi, ricordi e allegria, la totale esigenza di difenderne la memoria, il nome. Va tutto bene, tutti i sistemi rispondono, i ramponi cantano una canzone di forza e potenza ad ogni passo, la corda tesa lascia schizzare la neve a ogni dondolio, e quella vena profonda ruggisce una gioia segreta, privata, animale. Sono qui. Non mollo. Non ho paura. Non cederò mai.
Oltre la Porta Nera, l’alba taglia i pendii e forza le ombre. Scatto le prime fotografie della giornata, la Canon ora al collo, indosso gli occhiali neri e retrò, e qualcosa dentro ruggisce ancora più forte, riconoscendo il segnale. Le rocce alla base dell’immenso pendio sud della Roccia Nera sono rosse, compatte, oggi precedute da un elegante traverso di neve: un solco esposto nella parte superiore, che si alza senza deviazioni e menate, che mi chiama, che vorrei aggredire di corsa. Ma non faccio nulla di simile. Passo in testa, rallento con ogni cura il mio passo, perché la mia preziosa amica ha male ogni volta che alza la gamba destra. Le ho chiesto se volesse tornare indietro, e ha riso, sorpresa ma non offesa: lei non sta male, lei ha male, ma è viva e allegra come non mai. Ha solo voglia di salire. La sua canzone, quella che sente dentro, dev’essere perfino più forte della mia.
Le segnalo uno, due smottamenti. Qui allunga il passo. Il pendio ertissimo a destra del solco è traforato, merlettato, dalle picche di chi è salito prima.
Abbraccio le rocce, spolverate di terriccio grigio, fredde: vene nere di ghiaccio vivo si schiantano sotto i miei ramponi, sotto le quattro punte anteriori. Audrey regge bene la nostra corda, non dà suggerimenti ma c’è, e non mi dà corda se non occorre che me ne dia. Non mi stacca mai gli occhi di dosso. Un frammento di qualcosa vola giù, rimbalza nel camino angolato e color ocra in cui salgo, la Canon al riparo nello zaino; ci sono sassi dove so già che porrò piede tra un secondo, e poiché non posso rischiare che le facciano del male, li spazzo di schianto con il gomito, dentro la cavità che li ha creati. La giacca regge, il gomito anche. Mi acquatto contro la roccia e la roccia mi sorregge perfettamente, in punta di lame sono alto due metri, vedo già cosa ci aspetta oltre.
Ora sale lei, agile, sembra quasi non soffra. Le sue lame della Grivel si alzano tanto, sulla roccia ora grigia e ora rossa, che ne intravedo gli antisnow gialli. Audrey sale contro lo sfondo del Polluce, una mano sulla roccia, una sulla corda fissa che scende dall’alto, gli occhi bene aperti, indipendente e in gamba: un sogno di pura passione e competenza, totale autonomia. Viene su, sorride a cinquantadue denti, le stringo forte la spalla azzurra e riprendo a salire.
Abbiamo tre più due più due metri tra di noi, scanditi dai due nodi a palla: li ho un po’ ridotti ora, e ho molta corda nello zaino. La fissa che scende è lasca, ovvero assicurata solo in alto: Tarzan potrebbe usarla come liana e si impiglia nei massi, peraltro stabilissimi, che ci costringono a geometrie inusitate per due onesti piemontesi. Audrey si lascia sfuggire un Chissà come farò poi a scendere, ma capisco che sta parlando alla sua schiena. Neve, roccia, lama rossa, neve, destra, gradini, questa me la ricordo, il bivacco Rossi e Volante sulla sinistra. Un tedesco, già vestito e con una matassa a tracolla, si lava i denti guardandomi immobile. Ancora destra. Su. Gradino. Abbassarsi, lo zaino non passa. Sassi da non toccare. Ora dritto. Audrey puntualmente cede corda, non devo neanche fiatare. Grandi rocce rosse, sabbietta, neve negli interstizi, un vecchio cavo di ferro instabile, e sono su.
Recupero la nostra corda mentre lei, senza toccare alcunché, le mani pronte e le braccia allargate come un pistolero western preparato al peggio, raggiunge la grande terrazza nevosa e super panoramica soprastante il bivacco. Sta già ripescando la sua piccozza, doverosamente messa via durante la salita al Rossi e Volante. Camminiamo in salita per i primi cinquanta passi, prima che la canzone profonda si attenui, e mi volti a chiederle se vuole qualcosa. Beviamo un po’ del tè del rifugio, impazienti. Sopra di noi centinaia di metri di bianco surclassano ogni dimensione, parola, sensazione e descrizione: venti, trenta, quaranta gradi di pendenza prima che la cosa si inclini oltre il cielo e sparisca alla mia visuale, malgrado stia rischiando di cascare all’indietro da quanto piego il collo. Il tè, aromatizzato alla menta, è un incontro di wrestling tra zucchero e calor bianco, in scena nell’arena della mia gola. Audrey commenta qualcosa sul freddo circostante, e mentre muoio arso vivo dall’interno, non le rispondo perché fondamentalmente sono un gentiluomo.
Sono le sette e qualcosa. La traccia è ricamata sul pendio con precisione goniometrica, chiunque l’abbia ricreata dopo le nevicate dev’essere stato un artista: anche il Castore esibisce sulla sua Ovest un’uscita a destra, sulle roccette sottostanti la cima, non più la ripida e aerea traccetta verso l’anticima Nord Ovest da cui ero passato a luglio. Qui sulla Roccia Nera il solco descrive uno, tre zigzag prima di un lungo traverso in erta pendenza, e poi piega ardito verso sinistra, sparendo in alto. E’ dura per Audrey che sta vendendo tutto quel che ha, e ipotecando energie ancora da venire: io che correrei verso l’alto, in un’esplosione di bisogno di salire, mi invento un nuovo passo. Tre micropassetti, per non tirarla troppo, e una pausa di due secondi. Mi sento bene, sicuro, in forma, e non ho mai meno di tre punti d’appoggio sul pendio: un volo, qui, sarebbe fatale. La parete è in condizioni fantastiche, molto migliori dell’altra volta, ma evito di dirlo per ora alla mia amica: ci hanno preceduti i tre amici genovesi, Christian, Irene e il loro compagno, che si volta spesso a controllarci e che rassicuro ogni volta.
Aspetta, mi chiede lei ogni tanto, e mi fermo flettendo la gamba meno tesa. E’ curioso: lei ha fiato da vendere, maledice la sua schiena e l’anca, eppure soffre. E al contempo, malgrado soffra, non fa stupidaggini: è sempre bilanciata, è sempre assicurata alla perfezione con picca e ramponi. Ammirevole testona.
Vorrei che non finisse mai, questo gioco serio, questo momento di luce e neve e morso dei ramponi. Vorrei che non finisse mai, ma la mia preziosa amica soffre, ed è bene che finisca presto. 3900, dice il mio Suunto, poi ricordo un 4034, e questa volta prendo il numero e lo butto giù sul pendio verso Audrey, che raccoglie e rilancia con un L’altra punta te la scordi. Canticchio l’aria più celebre della Tosca, ed è probabilmente la prima volta che questo erto scivolo glaciale sente le parole stridea l’uscio dell’orto \ e un passo sfiorava la rena: ho qualcosa dentro che aspetta solo di ruggire, un senso inspiegabile a parole che nasce dall’essere qui, ora, e dal sentirmi a posto. Non banale euforia, bensì la consapevolezza istintiva dello stare bene, qui e ora, malgrado la mia insignificante piccolezza su questo colossale pendio. Poco ancora, e siamo su. In cresta. Niente vento.
La Roccia Nera non è banale, né semplice. Posto che esistano montagne banali, o semplici. Aggetta a nord, nel baratro affacciato sulla Confederazione e sul suo Gornergletscher, colossali cornici nevose; e verso destra, verso est, s’innalza di qualche metro in un’arguta, elevata pinna glaciale, che ne marca la cima. Alla ragazza genovese, sento, gira la testa; pochi passi ed in cima, seduta, fuma una sigaretta. Siamo in cinque, Audrey riprende colore e vita mentre la foraggio con tè caldo, cioccolata o forse albicocche secche, qualcosa che ho portato. Emozioni e parole nel vento, il Rosa adagiato innanzi a noi verso destra, la lama crudele del Lyskamm Occidentale, e verso occidente un filo che corre e riappare dietro le cornici della Roccia Nera, verso un pinnacolo di roccia rossa e neve biancoazzurra che si chiama, banalmente, Quota 4106.
Ne avevo accennato ieri, al rifugio, poiché chiunque guardi la Roccia Nera non fa a meno di notarla, e gli amici genovesi me ne avevano chiesto. Quassù, tra noi cinque, sono il solo ad averla già salita e solo dopo qualche secondo - l’orrore di Audrey nei suoi occhi, mentre mi ascolta proporre di andare a vederla - capisco l’equivoco: da qui, dalla vetta della Roccia Nera, i due Breithornzwillinge sembrano una cima unica, non due casualmente fuse insieme dalla prospettiva. Faccio leva senza alcuna remora su un’apertura di Audrey, che sospira, Però da qui il Cervino non lo vediamo, e dieci minuti dopo la partenza dei tre compagni di cordata genovesi, ci incamminiamo.
Raggiungo il fatidico bivio: a sinistra, signori si scende. Pianterreno: bivacco e articoli per l’arredobagno. Dritti, Quota 4106 e avventure assortite. Che si fa?
Andiamo su anche noi, sento, e qualcosa dentro sussulta.
Privilegiato, ho condiviso undici anni della mia vita con una splendida creatura di nome Tracey, un Pastore tedesco che amava mia mamma e la nonna, e che spesso, dal pavimento, emetteva un brontolio perennemente sul punto di mutare in ululato di gioia, quando capiva che parlavamo di lei, quando finalmente le chiedevo se volesse uscire per un giretto: quel brontolio muto, quella vibrazione sorda e pronta a esplodere in un ruggito, scala le pareti della mia gola mentre lascio la Roccia Nera dai molti nomi. Ma non emetto un decibel. Lei mi segue e tiene ben tesi i metri di kevlar che ci legano insieme. Poco prima, mi ha perfino ricordato di mettere la crema. Ha cura di me.
Dalla Roccia Nera alla 4106. Ritorno
In Ayas, c’è una Guida alpina di nome Stefano Percino. Non lo conosco, se non di vista, ma qualche giorno prima ha postato due fotografie su Facebook, e scommetterei qualche euro che la seconda lo ritraesse proprio qui.
Qui è il canalino che premette la base della Quota 4106, l’orientale dei due Gemelli dei Breithorn, i Breithornzwillinge, anche noti come Orientali dei Breithorn. La traccia che corre dalla Roccia Nera, in saliscendi a mezza costa dettati dall’andamento irregolare delle grandi cornici e dal buonsenso di chi è passato prima, costeggia sulla sinistra rocce innevate che celano il canalino: dieci metri, all’incirca, verticali e protetti ai lati da solida roccia, incrollabile, con buone fessure angolate sul lato destro di chi sale. Cioè, il mio.
Ai miei piedi si apre Ayas, coperta dalle nubi basse dell’inversione termica: non vedo nemmeno il Ghiacciaio di Verra da questa prospettiva da scala a pioli. Qualcuno, forse la Guida Percino o altri, ha scaricato la neve dal canalino, ed ora è accatastata in cumuli ai suoi ripidissimi piedi, come una microvalanga fossilizzata e aggrappata al pendio. Appena sopra, un paio di metri quadrati di neve a mò di terrazzino, affacciati sul Gornergletscher, mi danno modo di pensare ai miei fuggiaschi del 1943 e del 1944; recupero la corda mentre Audrey sale autonomamente. Ricordo quando mi ha detto che sarebbe venuta quassù per crescere, rispetto all’andare in montagna, e sorrido: la picca ora la impaccia, cambia mano, roccia, trova la fessura giusta, emerge alla luce, spalle e testa, è su con me. Fissa preoccupata il pendio soprastante e richiede come farà a scendere, questa volta a me, non alla sua schiena: le illustro le roccette ben pulite che emergono dalla neve, afferro la prima e la rimonto, la traccia è colma d’impronte e quasi verticale. Manca poco!, le dico, e anche lei sta salendo.
Una piccola vena di roccia senza neve, dopo un gradino rosso, mi porta in cima. Da qui lei sembra in verticale, non mi guarda fino alla fine, concentratissima. Tolgo i guanti, la roccia è calda, l’aria immota, il panorama immenso. E’ un gran momento, e i tre ragazzi genovesi ci accolgono allegri, è bello rivederli: la vista spazia sull’elegante lama del secondo Orientale, sulla cresta zigrinata del Centrale, sul mondo. E sul Cervino, così Audrey è contenta.
Scendiamo dalla 4106 con cautela. L’ultimo di cordata dei genovesi, l’elmetto arancione alzato verso di noi, ci guarda spesso per controllare che vada tutto bene: è una discesa breve, ma tecnica - non conviene inciampare o incasinarsi con la corda, qui - e un pò esposta. Ci sono molte roccette su cui poggiare, appoggiarsi o addirittura sedersi, all’occorrenza: ma il gioco di prospettive fonde tutto in un unico volo libero da qui al lago di nebbie che è Ayas, duemilacinquecento metri più in basso, e dal quale emergono solo la Testa Grigia a sinistra, il Grand Tournalin e la Becca di Nana a destra. Tutto sembra molto esposto, e passo avanti, per aiutarla come posso: risalgo, le indico dove ho messo i piedi un istante prima, creo il nostro microspazio di sguardi e braccia nel quale nascondere per qualche secondo l’enormità del vuoto che preme, silenzioso, alle mie spalle. Muovo le mani in fretta perché sia costretta a seguirle, per vedere dove ho messo i piedi, e distolga lo sguardo dall’abisso. In qualche modo questa psicologia spiccia funziona, oppure Audrey innesta l’ultima marcia, perché recuperando la corda scende con calma anche lei. Ora siamo al canalino, e qui fatico, perché ho impostato male la mia stessa discesa, e non è facile piroettare su sé stessi: una guida svizzera ha letteralmente issato un corpulento cliente, vestito da cacciatore e apparentemente semicosciente, occupando il terrazzino su cui contavo di voltarmi. Audrey fissa ammirata la guida, dicendomi qualcosa sul Guarda come gli fa sicura, a me ricorda piuttosto la pesca miracolosa dei marlin di George Clooney ne La tempesta perfetta.
Altro che marlin. Questi due mi costringono a passi troppo lunghi, perfino per le mie lunghe gambe nere. In un istante, ritrovo la roccia, e sotto metà del mio rampone destro si muove l’alta Val d’Ayas. Gulp!, direbbe Goofy, cioè Pippo. Tocca a te ora, dico invece verso l’alto con un sorriso sincero come una moneta da tre euro. Il Suunto ammicca sardonico, e sono le dieci di mattina sulla Quota 4106.
Il resto della discesa è, come direbbero nella perfida Albione che amo tanto, uneventful. Le due cime hanno ravvivato la mia amica come un’iniezione di qualche proibito cocktail ciclistico, e la nostra discesa lungo l’erta rampa di lancio della Roccia Nera è perfetta. Passo costante e veloce, sicuro. Ogni zigzag è segnato dall’immancabile cambio picca, la danza dei piedi sopra la corda, nel sole ora accecante: lei fa sicura dal tratto di traccia precedente, pochi passi nel nuovo corso, e tocca a me aspettarla. Senza dirle una parola, senza una voce, permettendoci di ammirare il Gran Combin o l’emergere del Monviso dalla zuppa, là in fondo. E’ la mia compagna di cordata preferita, non senza motivo: è una professionista, dura, tosta e preparata tipa bionda che non molla. Mi segue e se la cava, e mi sorprendo a pensare che, se improvvisamente io sparissi - un crepaccio, una frattura spaziotemporale, un’abduction degli alieni o della CIA - Audrey sarebbe perfettamente in grado di rientrare al rifugio da sola, mentre altra gente che ho conosciuto si siederebbe aspettando i soccorsi, la morte, i Marines, la fatina dei denti. Non percepisco nulla, nel mio arsenale d’inventiva e capacità, che non credo lei possegga; io sono lei, con la fortuna di non avvertire alcun dolore o stanchezza. Giochiamo su questo pendio in un balletto di volte e cambi di picca, trazione e successivo rilascio; i tre simpaticissimi genovesi ci aspettano alle rocce della grande terrazza che sovrasta il bivacco, dove la nostra mission impossible si rivela l’orchestrare cinquanta secondi privi di alpinisti, guide, clienti, marlin e morti-di-sonno per consentire alla mia amica di far pipì in pace. Difficile, poiché la Guida svizzera e il cliente-cacciatore-più in là che di qua hanno rinunciato alla 4106 e ci tallonano.
Tè, zuccheri, calorie, risate. E’ bello qui. Scendiamo bene, lungo le roccette e nel canalino oltre il Rossi e Volante, attendendo a lungo perché sotto di noi ci sono i tre genovesi e se ci attaccassimo alla corda fissa, potremmo sbilanciarli e scaraventarli nel vuoto bianco. Oltre il traverso sul pendio dell’andata, Audrey mi chiede perché corro, e in effetti, sto correndo. Rimontiamo a passo più lento il pendio antistante al Polluce, la grande Porta Nera alla sinistra, e scendiamo con immensa cautela verso le nere rocce di Lambronecca nel calore accecante: il riverbero mi lascia immagini complesse, impresse sulla retina. Una di esse consiste in una Guida alpina con cinque clienti, sei persone legate insieme!, tutte e sei prive di ramponi su un tratto noto per i propri crepacci. Devo aver certo sognato. Nessuno di loro aveva un oggetto a forma di picca in mano.
E’ mezzogiorno, quando ogni cosa comincia a riprendere colore e profondità, grazie alle nubi che ora mi proteggono la vista. Disfo lo zaino facendo asciugare ogni cosa, monopolizzando la terrazza del Guide d’Ayas, da cui ripartiremo solo alle 13.10.
E’ dura salutare i miei amici del Mezzalama, questa volta, ma i ragazzi genovesi ci fanno ghignare allegramente e - quattro contro uno - si è deciso di prendere il taxi NCC della Carrozza: faccio buon viso a cattivo gioco, ma l’appuntamento è per le 15.15 ai gradini del sentiero 7, al Pian di Verra. Lasciamo il Rifugio Ottorino Mezzalama solo alle 14.18, e la corsa successiva farà uggiolare Audrey a ogni singolo scalino - perfino quelli innocenti del Cadran Solaire di Antagnod - fino al giorno dopo.
Tanto, il giorno dopo, pioverà.